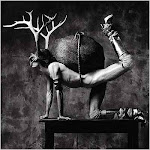Silvia non andò a prenderlo neppure all’aeroporto. Troppo caldo, aveva detto. Certo c’era una bella differenza dall’ultima volta che era stato a Milano. Il tassista attraversò la città semideserta nella calura d’agosto con i finestrini oscurati e l’aria condizionata a palla e lo scaricò in Via Stradella 4, senza dire una parola per tutto il viaggio.
Stanotte la moglie non gliel’avrà data, pensò il ragazzo; pagò e scese senza salutare.
Silvia accolse l’ex amico in sottoveste nell’ampio soggiorno dell’appartamento dei suoi genitori. La casa era completamente cambiata, ma il ragazzo riconobbe il tavolo in cucina dove si sedevano a fare i compiti al liceo. Silvia nel frattempo aveva incontrato Max, un bel ragazzo dagli occhi buoni che disegnava stampe per un’azienda di tessuti sul lago di Como e che Davide chiamava papà.
 Il bambino era diventato un uomo: alto, biondo e con gli occhi azzurri come la madre. Aveva la spensieratezza e l’atteggiamento dinoccolato tipico dei pargoli benestanti della sua età, ma senza la spocchia e la malizia dei suoi coetanei americani. Non sembrava aver sofferto più di tanto per la sua infanzia travagliata e la tragica morte dei nonni che per lui erano stati dei veri e propri genitori, visto che Silvia era sempre al lavoro e aveva trovato una relativa stabilità affettiva solo con il suo attuale compagno. Il suo sguardo era diretto e limpido. La sua stretta di mano decisa ma accogliente. Il suo tono di voce suadente ma virile. Il ragazzo fu presentato a Davide come un vecchio amico della mamma. E come dargli torto, dato che l’aveva visto sì e no un paio di volte, escluso quando era in fasce? Dopo i convenevoli di rito Max e Davide uscirono con una scusa e lasciarono Silvia e l’amico in casa da soli.
Il bambino era diventato un uomo: alto, biondo e con gli occhi azzurri come la madre. Aveva la spensieratezza e l’atteggiamento dinoccolato tipico dei pargoli benestanti della sua età, ma senza la spocchia e la malizia dei suoi coetanei americani. Non sembrava aver sofferto più di tanto per la sua infanzia travagliata e la tragica morte dei nonni che per lui erano stati dei veri e propri genitori, visto che Silvia era sempre al lavoro e aveva trovato una relativa stabilità affettiva solo con il suo attuale compagno. Il suo sguardo era diretto e limpido. La sua stretta di mano decisa ma accogliente. Il suo tono di voce suadente ma virile. Il ragazzo fu presentato a Davide come un vecchio amico della mamma. E come dargli torto, dato che l’aveva visto sì e no un paio di volte, escluso quando era in fasce? Dopo i convenevoli di rito Max e Davide uscirono con una scusa e lasciarono Silvia e l’amico in casa da soli. 
“Perché?” gli disse Silvia senza tergiversare, appena sentì chiudere la porta.
La mammità, l’età e tutto il resto non l’avevano cambiata neanche un po’. Aveva conservato intatti i modi diretti e il piglio deciso della sua giovinezza. Il suo sguardo freddo, occhi negli occhi, non lasciava via di scampo. Aveva sempre odiato le bugie e adesso voleva la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità. Il ragazzo lo sapeva ma fece finta di non aver sentito per prendere tempo.
“Perché, cosa?”
“Perché, Andrea? Perché un nome falso? Perché dare all’uomo della tua vita, a tuo marito o come cazzo vi chiamate tra di voi, il tuo nome di battaglia? Lo stesso nome falso che riservavi ai tuoi incontri occasionali. Quelli da una scopata e via come dicevi tu. Quelli che non avresti più rivisto, che comunque non se lo meritavano di conoscere il vero te stesso. Bla bla bla… La tua bella anima candida! Bella predica davvero. E da che pulpito!”
“Tu non capisci”.
“Capisco benissimo invece. Quello che non capisco è perché l’hai fatto proprio a me.
Come se non lo sapessi quanto detesto le bugie. E per giunta davanti all’altare! Che patetica messinscena”.
“Giusto, scusami. Perché solo voi potete sposarvi, vero? Noi no, maledetti sodomiti che non siamo altri!”
“Cos’è, fai la vittima? Guarda che con me non attacca. Per me chiunque può sposarsi con chi cazzo gli pare, figurati! Bastasse un pezzo di carta ad assicurare il successo di un’unione… E comunque perché scimmiottare il matrimonio etero? Come se ormai non fosse ampiamente dimostrato dai fatti che è la più grande cazzata di tutti i tempi. Altro che sacramento! Sposarsi… per giunta con il doppio rito: ebraico e cattolico? Come se uno solo non bastasse. Quanto zelo! Degno di miglior causa, davvero. Congratulazioni vivissime, Andrea Coiro! Vuoi tu prendere in sposo il qui presente Andrea, Luca, Giovanni o come cavolo ti chiami… nella buona e nella cattiva sorte?”
“Piantala!”
“Ed amarlo e rispettarlo finché morte non vi separi? Bel rispetto davvero!”
“Non infierire ti prego…”
“’Sì, sì, lo giuro davanti a Dio. Per sempre!” continuò Silvia, scimmiottando la risposta del ragazzo all’altare con la voce emozionata e l’atteggiamento sinceramente contrito di un chierichetto.
”Se esistesse un Dio, su quel altare avrebbe dovuto fulminarti con lo sguardo. Lui, non io!”
“Lascia che ti spieghi, almeno…”
Silvia era fuori di sé dalla rabbia. Non voleva sentire ragioni e continuava a urlargli in faccia le sue colpe, rossa in viso come un’ossessa.
“Per sempre. Per sempre bugiardo, ecco cosa sei! Me l’avevi già fatto una volta, ricordi? Con quel conte del cazzo e il suo Nicola di Bari... E io ti avevo perdonato. Che stupida sono stata a fidarmi ancora di te. Di questa bella faccia d’angelo, dei tuoi piagnistei, della tua tanto sbandierata sensibilità, della tua pesante verità. Del tuo insostenibile segreto. Me lo porto ancora sulle spalle quel fardello, sai? La tua vita, la tua malattia, la tua disperazione e la tua speranza. L’ho nutrita io quella speranza, per tutto questo tempo. Come una serpe in seno l’ho nutrita. Col mio silenzio. Con la mia complicità. Ma adesso è arrivato il tempo di dire la verità. Ti ho fatto venire qua per questo. Per vedere se sarai ancora capace di mentire anche di fronte ai 18 anni di mio figlio. Voglio proprio vedere che insegnamento gli darà lo zio d’America per il suo futuro. Vivere nella verità e nella luce come andavi pontificando ai tempi del liceo, o accontentarsi della menzogna quando ti fa comodo? Rispondi!”

“E’ inutile. Tu non puoi capire come ci si sente a essere…”
“Sieropositivo? Dillo. Che male c’è? E’ una malattia come un’altra, anzi oggi è anche meno peggio di tante altre. Una malattia, mica una colpa, l’hai detto sempre tu. Cos’è, ora ti vergogni? E di che cosa? Della malattia, di Luca o di te stesso?”
“Non osare nemmeno pronunciare quel nome!” gridò il ragazzo fuori di sé dalla rabbia.
Silvia sgranò gli occhi e rimase impietrita quando le arrivò il ceffone. Sentì la guancia bruciare e immaginò il segno lasciato dalle cinque dita del ragazzo. Gli occhi le si riempirono di lacrime. Un sentimento nuovo, profondo e sconosciuto si fece strada faticosamente ma inesorabilmente dentro di lei. Era odio quello? Silvia non osò pronunciare il suo nome; lo scacciò via dalla sua mente come una maledizione, come un veleno mortale. Perché la vita le aveva insegnato che l’odio non perdona, ma avvelena l’anima di chi lo prova fino ad ucciderlo e la vita umana è così fragile, così precaria e così breve. E l’odio è pur sempre un sentimento, come l’amore. Uguale e contrario. Il ragazzo sostenne lo sguardo di Silvia con la forza di quel amore per un tempo che sembrò infinito finché i due vecchi amici si strinsero piangendo in un abbraccio, l’espressione più sincera del perdono.