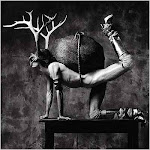La spia rossa della segreteria di casa indicava che c’era un messaggio in attesa. Era Silvia. Singhiozzava. Aveva provato sul suo maledetto cellulare ma a Provincetown non c’era campo. I suoi erano su quel aereo. Erano precipitati all’una di notte sopra il Mare del Nord, di ritorno dal loro viaggio a Stoccolma. Il pilota aveva tentato l’ammaraggio ma un’ala aveva colpito l’acqua. L’aereo s’era spezzato in due ed era esploso immediatamente.
Il ragazzo sbiancò. Singhiozzava così tanto da non riuscire a spiegare ad Andrew cosa fosse successo. Gli fece segno di riavvolgere il nastro e riascoltare il messaggio da sé.
Andrew ormai conosceva abbastanza bene l’italiano e non gli ci volle molto per collegare le parole di Silvia alla notizia ascoltata in macchina e al racconto del ragazzo. Il ragazzo fece un veloce calcolo mentale: l’una di notte in Italia erano le cinque del pomeriggio a New York. L’aereo era caduto esattamente nello stesso momento in cui aveva fatto il sogno dell’incidente. Ma non lo disse a Silvia quando le telefonò per avvisarla che avrebbe preso il primo volo per Milano.
Trovò la città coperta da una spessa coltre bianca. Nessuno ricordava una nevicata così da almeno 30 anni. Tanto meno lui. In una sola notte erano venuti giù 35 centimetri di neve. Le strade erano bloccate. Le scuole chiuse. Solo l’intervento dei camion spargisale aveva consentito al suo Boeing 747 di atterrare. Naturalmente, di fingers neanche a parlarne. Dovette aspettare altri 10 minuti buoni che il bus di collegamento si facesse strada tra i cumuli di neve e li caricasse per riportarli all’aerostazione di Malpensa. Povera Italia, pensò il ragazzo e si preparò ad affrontare la giornata con santa pazienza. Le esequie si svolsero nella chiesa di S. Marco. Silvia aveva lasciato Davide a casa con la babysitter.