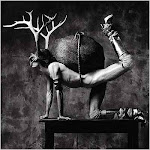L’ebreo neanche gli rispose. Il negozio era vuoto, lui era l’unico cliente e non riusciva proprio a capire il perché di tanta maleducazione. Nulla poteva giustificare un simile comportamento, specialmente da parte di quel vecchio commerciante ebreo che pure doveva aver sperimentato sulla propria pelle quella stessa mancanza di riguardo, quella stessa odiosa indifferenza che ora stava riservando a lui. A parte la differenza d’età le esistenze di quel ebreo disilluso e di quel giovane omosessuale confuso erano accomunate dal medesimo destino di discriminazione e sofferenza. Una condizione comune e un comune sentire, proprio come diceva la lettera di Silvia –si disse- e ancora una volta il pensiero tornò all’amica e ai tempi del liceo. Ma fu solo per un breve istante. Il ragazzo non ebbe neanche il tempo di riaversi dalla sorpresa che il proprietario l’aveva già scaraventato fuori dal negozio, inveendo contro di lui e la sua bici di merda.
Ritornando a casa a piedi in preda a una tremenda tensione -testa bassa e pugni serrati sul manubrio della bici- con un mare di rabbia pronta a esplodere in un pianto dirotto, il ragazzo si sentiva ancora più confuso di quando era uscito. Cosa gli stava succedendo? Era stato come vedersi dal di fuori, incazzato col mondo intero senza sapere perché e senza riuscire a controllarsi. Sul lungotevere che lo riportava a casa, spompato come le ruote della sua bici, cercò di analizzarsi meglio. La sua era una vita piena di avventure e