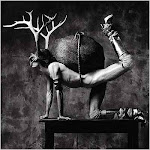Il Palladium era strepitoso. Michael dovette incaricarsi del guardaroba. Il ragazzo s’era incantato ad ammirare l’enorme scalinata in vetro trasparente e i mille led luminosi dei gradini che creavano un effetto psichedelico riflessi dal soffitto a specchio. C’erano tre sale al primo piano, ma le due laterali erano state trasformate in immense darkroom dietro pesanti tende di plastica nera. Nei due corridoi che s’erano venuti a formare ai lati della pista centrale si svolgevano delle vere e proprie sfilate di moda. Drag-queen vestiti solo di piume e minigonne incedevano su vertiginosi tacchi a spillo con un’eleganza da far invidia a qualsiasi donna. Quando Vasquez mixò Vogue di Madonna accadde l’incredibile. Praticamente l’intera discoteca si bloccò e tutta la gente in pista si divise in due enormi ali di folla che si fermarono ad ammirare i catwalk improvvisati da quelle modelle in agguerrita competizione. Sguardi affilati come stilettate, espressioni altere, trucco impeccabile, portamento marziale: quei trans erano le copie in carne e ossa delle modelle di carta che il ragazzo ritagliava dalle riviste della mamma. Gli applausi della folla decidevano chi andava e chi restava dopo ogni scontro a due, finché i due vincitori si sfidarono a singolare tenzone al centro della pista. Il ragazzo era salito su per godersi meglio la scena. Al piano di sopra c’era un’altra grande sala immersa nell’oscurità e occupata per metà da un castello gonfiabile come quelle per bambini, ma dieci volte più grande. Ondeggiava di qua e di là, sussultando come durante un terremoto. Ogni tanto da un’uscita laterale veniva fuori qualcuno tutto sudato: chi a torso nudo, chi con i pantaloni e le scarpe in mano.
Il Palladium era strepitoso. Michael dovette incaricarsi del guardaroba. Il ragazzo s’era incantato ad ammirare l’enorme scalinata in vetro trasparente e i mille led luminosi dei gradini che creavano un effetto psichedelico riflessi dal soffitto a specchio. C’erano tre sale al primo piano, ma le due laterali erano state trasformate in immense darkroom dietro pesanti tende di plastica nera. Nei due corridoi che s’erano venuti a formare ai lati della pista centrale si svolgevano delle vere e proprie sfilate di moda. Drag-queen vestiti solo di piume e minigonne incedevano su vertiginosi tacchi a spillo con un’eleganza da far invidia a qualsiasi donna. Quando Vasquez mixò Vogue di Madonna accadde l’incredibile. Praticamente l’intera discoteca si bloccò e tutta la gente in pista si divise in due enormi ali di folla che si fermarono ad ammirare i catwalk improvvisati da quelle modelle in agguerrita competizione. Sguardi affilati come stilettate, espressioni altere, trucco impeccabile, portamento marziale: quei trans erano le copie in carne e ossa delle modelle di carta che il ragazzo ritagliava dalle riviste della mamma. Gli applausi della folla decidevano chi andava e chi restava dopo ogni scontro a due, finché i due vincitori si sfidarono a singolare tenzone al centro della pista. Il ragazzo era salito su per godersi meglio la scena. Al piano di sopra c’era un’altra grande sala immersa nell’oscurità e occupata per metà da un castello gonfiabile come quelle per bambini, ma dieci volte più grande. Ondeggiava di qua e di là, sussultando come durante un terremoto. Ogni tanto da un’uscita laterale veniva fuori qualcuno tutto sudato: chi a torso nudo, chi con i pantaloni e le scarpe in mano. Il ragazzo si accostò incuriosito all’ingresso più vicino ma non riuscì a vedere niente. All’interno era tutto un intrico di tunnel scuri in cui si intravedevano ogni tanto corpi avvinghiati in strane evoluzioni.
Quando il ragazzo fece per tornare indietro si accorse con piacere che quel bel manzo con i pettorali da urlo che aveva adocchiato giù in pista era dietro di lui. C’aveva visto giusto allora. Almeno a giudicare da quel grosso bozzo che puntava dritto verso di lui, sotto i pantaloni della tuta quel tipo non doveva portare le mutande. Non ripeté l’errore fatto ad Amsterdam. Approfittando della calca e con l’alibi del tiro di key che Andrew –così si chiamava- gli aveva appena offerto, gli fece un accurato check-the-basket.