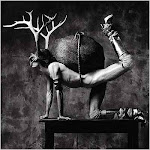giovedì 25 marzo 2010
Sogno n° 3
Sono sul Gianicolo a Roma, alla guida di un enorme autobus turistico bianco a due piani. A bordo ci sono anche il mio compagno, mio fratello e un suo amico.
mercoledì 24 marzo 2010
Olga (IV parte)
Raduno estivo, Perugia. Esterno giorno.
I vampiri della nazionale non contenti del sangue che gli facevano sputare ogni giorno in pista né di quello che gli avevano prelevato durante tutta la settimana di allenamenti, volevano assaggiare anche la sua carne. Giusto un pezzetto di quadricipite per conoscere la ricetta del successo del ragazzo, avevano detto ai genitori.
Più fibre bianche = 400 ostacoli. Più fibre rosse = 110 ostacoli. La risposta non arrivò mai. Giace ancora sull’asfalto della provinciale Perugia-Roma dove per un incidente dell’auto che lo trasportava in laboratorio, il bidone dell’azoto liquido si rovesciò, spargendo in terra il prezioso campione muscolare del ragazzo insieme a quelli di tutti gli altri allievi della nazionale, come le foglie della Sibilla Cumana sparse in terra.
Dopo la prima settimana a Perugia fu la volta dei raduni mensili a Formia. Che bello era prendere il treno e ritrovarsi con i compagni velocisti alla scuola nazionale di atletica leggera insieme a Mennea, la Simeoni e ai tanti altri campioni con cui si condividevano sudore e sogni, risate, lacrime e sangue.
Gli ostacolisti erano i più coccolati perché riunivano velocità, potenza e coordinazione a quel non so che di misterioso, unico e indefinibile che viene comunemente chiamato stile. Si faceva a gara per tutto: per l’uscita più rapida dai blocchi, il passaggio più elegante sugli ostacoli, la maggiore reattività in pista e, naturalmente, lo stacco di coscia più alto e la calzamaglia più attillata. D’estate poi era un tripudio di corpi depilati e ben oliati, narcisisticamente esposti in bella vista con la scusa dell’abbronzatura.
“Sesso che cammina” diceva il ragazzo, anzi che corre. Lo sapevano anche loro, i vampiri della nazionale che era impossibile tenere a freno gli ormoni impazziti di quegli adolescenti, nel pieno vigore delle loro forze. Per questo gli mettevano il bromuro nel latte e li chiudevano a chiave nelle camerate di notte, per evitare che andassero a insidiare le compagne atlete. Ma chi ci pensava alle ragazze. Loro bastavano a se stessi. Tutto cominciò per gioco, grazie a un numero di Playboy che il ragazzo aveva trafugato dall’armadietto di un massaggiatore. Nel corridoio in fondo alle camerate c’era una fotocopiatrice. Di notte i ragazzi si passavano la rivista e quando l’eccitazione si faceva largo dentro i boxer lo tiravano fuori, lo poggiavano sul vetro e lo fotocopiavano. Poi misuravano il risultato con la fettuccia per il salto in lungo. Presto diventò quella la gara più eccitante per il ragazzo. Non gli era mai piaciuto fare addominali.
“Con la tararuga ci nasci, ma non ci diventi” si consolava lui con gli altri. Ma nel segreto della sua stanza si sottoponeva a infinite serie di crunch, prima e dopo ogni allenamento.
“Gli piacciono gli addominali al tuo amichetto, eh?” gli disse un giorno il suo nuovo allenatore. “Se non la smetti di frequentare quella gente lo dico ai tuoi genitori” concluse, gelando il sangue del ragazzo davanti a tutti i suoi compagni di squadra.
Lui fece finta di niente ma sentiva una rabbia antica montargli dentro. Trovava tutto così ingiusto e umiliante. Un furtivo scambio d’occhiate col suo fedele compagno di allenamenti gli confermò che i suoi sospetti erano fondati. Quell’infame oveva aver parlato. Cominciò a dubitare della lealtà del compagno con cui s’era confidato ma si sentiva abbastanza tranquillo. Quel bastardo di allenatore in fondo non aveva prove. All’epoca il ragazzo frequentava solo un paio di locali privati, perciò dovunque l’avesse beccato quel ficcanaso figlio di puttana doveva essere dell’ambiente pure lui. E un frocio sposato con due figli di sicuro aveva molto più da perdere di lui. Comunque il ragazzo aveva preso le sue precauzioni e quando si ripresentò dai suoi per il suo compleanno, si portò dietro una fidanzata in carne ed ossa. Parecchio in carne per la verità. Fulvia era alta, grossa e alquanto ingenua, ma abbastanza cotta di lui da credere alla raffazzonata storia del suo dis-orientamento sessuale e candidarsi con piacere per redimerlo e riportarlo sulla retta via. La mamma del ragazzo, conoscendo l’ossessione del figlio per l’estetica dovette rimanere alquanto sorpresa alla vista di quella valchiria dal marcato accento romanesco e dal modo non esattamente raffinato con cui sorbiva il brodo dei suoi tortellini fatti in casa. Ma l’affetto sincero che dimostrava per suo figlio la rassicurò a tal punto che il pranzo scivolò liscio come l’olio verso un sonnacchioso pomeriggio domenicale. L’unico ad essere visibilmente sollevato sembrava Pietro che, sebbene non giudicasse esattamente Fulvia come una Venere di Milo, la riteneva una ragione sufficiente per fugare i dubbi e le insinuazioni sempre più pressanti dei suoi amici sulla chiacchierata omosessualità del fratello. Il ragazzo -che non aveva mai creduto nelle coincidenze- avrebbe dovuto capirlo subito che quella farsa non avrebbe retto a lungo. Ma quando si accorse di aver perso la carta d’identità non colse il segno premonitore dell’imminente tragedia. Appena rientrò a casa dopo aver fatto la denuncia di smarrimento alla vicina stazione di polizia, al ragazzo fu chiaro che l’allenatore aveva mantenuto la promessa, anzi la minaccia. Era bastata una telefonata per mandare tutto a puttane e trasformare la valchiria di rappresentanza in un ammasso tremolante di carne umana. Quando il ragazzo la vide piangere insieme ai suoi genitori sul divano blu dell’ingresso confessò tutto come un fiume in piena che rompe gli argini. Non era più tempo di scappare. Lui era cambiato ed era ormai pronto ad affrontare la realtà senza paura. Non si spaventò nemmeno quando sentì l’eco di quelle parole rimbombargli dentro per l’ultima volta: “Morirai a 19 anni”. Da quel momento il ragazzo giurò di chiudere per sempre col passato, anche se sapeva di dover dire addio al suo grande amore per l’atletica. Guardava i legni di tutti gli ostacoli che aveva superato passargli davanti, trascinati via dalla corrente in piena della sua nuova vita. Era morto e risorto e n’era felice. Aveva appena compiuto 19 anni.
martedì 23 marzo 2010
Olga (III parte)
Paura. Ecco cosa spinge un ragazzo di 17 anni a svegliarsi alle 7 ogni mattina, domenica compresa, correre in salita trascinandosi dietro un copertone piombato sotto il sole, la pioggia o il vento gelato. Ogni mattina scendeva di corsa i quattordici scalini in marmo bianco tra l’ascensore e il portone d’ingresso del palazzo e poi gli ultimi due gradini neri di pietra che davano sulla strada. Quattordici secondi e due centesimi: il record italiano allievi sui 110 ostacoli. Era un segno del destino. Ormai era diventato il suo chiodo fisso. Pensava solo a quello, giorno e notte. Qualcuno, qualcosa dentro di lui gli diceva di non mollare, che ce l’avrebbe fatta. Che era solo questione di tempo. Così il ragazzo cominciò ad allenarsi duramente, costantemente, caparbiamente. Sentendosi ogni giorno meno confuso, meno triste, meno sconfitto ma non più felice. Meno arrabbiato e
Era un bel sabato d’inizio estate a Roma. Il ragazzo aveva lavorato sodo tutto l’anno. Era al massimo della forma e lo sapeva. Ma c’era il solito problema dell’emozione che lo tormentava. Per fortuna arrivò allo stadio dei Marmi così in ritardo che non ci fu neppure il tempo per pensare. A stento aveva un quarto d’ora per scaldarsi ma faceva caldo e i muscoli erano già bollenti sotto la calzamaglia blu e nera della Nike.
Lo capì subito che quel giorno sarebbe successo qualcosa di straordinario. Il leggero vento a favore, i mulinelli d’aria calda che si sollevavano a ondate dalla pista bollente facendo tremolare i corpi nudi dei giganti di marmo come miraggi davanti ai suoi occhi, la consistenza magmatica del tartan, il silenzio carico d’attesa del pubblico sugli spalti, dell’allenatore e di tutti i suoi compagni di squadra. Tutto aveva un che di sovrannaturale. A causa del ritardo al ragazzo fu assegnata la prima corsia e non quella centrale che spetta di diritto a chi detiene il miglior record personale. Ma la cosa non lo disturbò più di tanto. L’allenatore non mancò di sporgere reclamo al giudice di gara, più per guadagnare tempo per il riscaldamento del ragazzo e per innervosire un po’ i suoi avversari che per altro. Lo sapeva benissimo anche lui che la prima corsia è la migliore per chi attacca gli ostacoli con la destra, perché puoi passare la seconda gamba leggermente più bassa e un po’ esterna alle barriere; quel tanto che basta a guadagnare preziosi centesimi di secondo. Mentre lo starter elencava i nomi dei concorrenti e i rispettivi record personali il ragazzo sistemò i blocchi, strinse forte i lacci delle scarpe chiodate e si sedette, aspettando che l’ansia se ne andasse. Tirò fuori dallo zainetto di tela lo specchietto rotondo e si guardò. Vide la paura nascosta in fondo agli occhi, i suoi begli occhi scuri, sotto l’arco gentile delle sopracciglia. Riconobbe i segni della tensione trattenuta nella linea sottile delle labbra che gli tagliava la bocca in due di netto. Seguì le gocce di sudore che gli imperlavano la fronte ampia e gli gocciolavano di lato sulle tempie dove il sangue pulsava all’impazzata. E cominciò a respirare profondamente. Fece uno, due, tre respiri. Ampi e profondi, ampi e profondi, ampi e profondi. Finché la paura di quel ragazzo che fuggiva rincorso dai compagni di scuola che gridavano
“Quattoridici e due! Quattoridici e due!” urlò l’allenatore. Ma il ragazzo non lo ascoltava. Sentiva solo che finalmente era finita.
lunedì 22 marzo 2010
Olga (II parte)
Prendeva le forbicine per le unghie dalla scatola d’argento di sua mamma, sceglieva il lato della pagina con la modella più carina e cominciava a ritagliare. Era di una precisione sconcertante, ai limiti della mania. Poteva passare una mattinata intera a ritagliare la sagoma di una sola modella. Non si lasciava sfuggire neanche un dettaglio. L’unghia di un dito, il bordo di un cappello, le frange di una sciarpa, una ciocca di capelli per quanto sottile fosse, lui non la tagliava: la cesellava con le forbicine. Ricopriva tutto il letto con una miriade di triangolini e striscioline di carta patinata così sottili che a sua mamma non riusciva di toglierli neppure con lo scotch ed era costretta a passare l’aspirapolvere sul copriletto merlettato per delle ore. Una volta ritagliate le figure, il ragazzo dava un nome a ogni modella prendendo spunto dal colore degli occhi o dei capelli, da un dettaglio dell’abbigliamento, oppure inventandoli di sana pianta. Quella era la parte più bella. Dopo il meticoloso lavoro manuale in cui si costringeva ad una rigida disciplina, poteva finalmente concedersi il lusso di volare libero sulle ali della fantasia. Angel era la sua preferita. Due occhi azzurri tagliati di sghimbescio, sopracciglia ad ala di gabbiano come Marilyn e quell’aria così snob. Sicuramente aveva il sangue blu. L’aveva ritagliata in due versioni: quella da sera in abito lungo, tacchi a spillo e un lungo bocchino alla Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany; l’altra look sportivo-elegante con una folta chioma bionda fasciata in un foulard color cremisi, pantaloni a pinocchietto bianchi e una minuscola pochette in acciaio e swarosky stretta in pugno: un’arma impropria più che una borsetta. Proprio così. Perché dopo il ritaglio e il battesimo iniziava la battaglia. La selezione era rigida e spietata, come per una sfida olimpica con tanto di teste di serie, batterie, semifinali e finali che sancivano la supremazia della più bella e della più forte, finché non ne restava solo una. Spiegazzata, tagliuzzata, mutilata a volte, ma assoluta vincitrice. Era una guerra senza esclusione di colpi. Cominciava sempre con una rapida schermaglia a base di algide occhiate e acidi commenti in falsetto, imitando la voce della mamma con la cameriera, il portiere, o quando rimproverava il garzone del salumiere perché la mozzarella non aveva “la goccia”. Solo dopo aver studiato l’avversaria e individuato i suoi punti deboli, la battaglia vera e
propria aveva inizio. E Angel vinceva sempre. Così, una febbre dopo l’altra, il ragazzo allenò la sua voce a raggiungere altezze proibitive per un maschio. Finché scoprì il ruggito della tigre di Cremona. Ogni pomeriggio dopo pranzo, nei giorni in cui il papà medico non faceva le visite in casa, aspettava pazientemente che la mamma finisse il suo beauty sleep e uscisse, e si metteva le cuffie. Poi accendeva lo stereo, prendeva un disco di Mina e poggiava delicatamente la puntina sul primo solco del 33 giri. Ormai conosceva tutte le parole delle canzoni a memoria e le seguiva come in un karaoke, con la sua voce bianca da adolescente, senza perdere neppure un’ottava.
Alla radio andavano forti anche le canzoni americane e sulla via di scuola il ragazzo si sorprendeva a recuperare il ritardo accumulato a colazione -con la tesa penzoloni e gli occhi cisposi davanti alla tazza del caffellatte- saltellando al ritmo di questa o quella canzone dalla cadenza vagamente anglofona, le cui uniche parole comprensibili erano i nomi delle sue eroine di carta. Fu così che il ragazzo imparò contemporaneamente due cose che si sarebbero rivelate molto utili per il suo futuro: correre veloce e parlare inglese.
Furono proprio la sua vocina, i suoi boccoli biondi e i suoi modi gentili, gli stessi che solo fino a qualche anno prima gli avevano guadagnato le simpatie incondizionate di compagni e insegnanti, a tirargli un brutto tiro. Tutto ebbe inizio un lunedì dopo le vacanze estive. Il ragazzo aveva fatto una delle sue puntuali obiezioni, quando la morbida chioma bionda della prof di lettere ebbe un tremito e dopo aver compiuto un mezzo giro su se stessa sotto il fascio di luce che filtrava dalla finestra sul cortile, rivelò l’orrendo volto di un’erinni. Il ragazzo non poté credere alle sue orecchie quando la sentì dire acida davanti a tutta la classe:
“Innanzitutto non è questa la voce con cui dovrebbe esprimersi un ragazzo della tua età. E poi faresti meglio a non interrompere di continuo la lezione con le tue domande!”
Da quel giorno all’uscita di scuola tutti cominciarono a chiamarlo femminella.
Il ragazzo smise di cantare le canzoni di Mina e cominciò a usare tutto il fiato che aveva in corpo per sfuggire alle imboscate dei suoi compagni di scuola che, sentendosi legittimati dalla sparata della prof di lettere, si erano trasformati improvvisamente nei suoi più temibili persecutori.
venerdì 19 marzo 2010
Olga (I parte)
E pensare che il ragazzo era approdato all’atletica solo per sfuggire alla concorrenza di Piero, il fratello maggiore che puntualmente lo stracciava a tennis. Era una battaglia impari perché per un ragazzo di 14 anni, due anni di differenza sono tanti. E non era l’unica battaglia che combatteva contro di lui. Quand’erano piccoli lui e il fratello giocavano sempre ai soldatini. Quanti ce n’erano in quella vecchia scatola di biscotti. Saranno stati un centinaio, tra indiani e cowboy. Una lotta per decidere chi prendeva i cowboy. Una lotta per accaparrarsene il maggior numero possibile, con dieci tiri di dadi. Li allineavano in una lunga fila sul parquet, ai lati opposti della stanza. L’ultimo tiro di dadi decretava chi doveva lanciare per primo la biglia matta contro le fila nemiche. Si andava avanti, un lancio ciascuno, finché tutti i soldatini avversari non erano riversi a terra. Niente giochi di sponda sulle pareti laterali. Era quella la regola che causava più problemi perché una volta lanciata la biglia matta era impossibile prevedere i suoi rimbalzi. Non si sa come, finiva sempre che vinceva suo fratello. Allora lui si metteva a urlare con quanta voce aveva: NON VALE! NON VALE! NON VALE! Poi, accecato dalla rabbia si gettava sui soldatini nemici superstiti e li spazzava via con una manata. A quel punto Piero perdeva la pazienza e cominciavano a menarsi. Il ragazzo si metteva sulla schiena scalciando da ogni parte come un pazzo e rendendo praticamente impossibile al fratello mettere a segno uno dei suoi terribili pugni. Quando le cose si mettevano male, papà urlava di finirla dallo studio e arrivava la mamma. Fulminava il fratello maggiore con lo sguardo, asciugava le lacrime al più piccolo con un tovagliolo e se lo portava in cucina dove gli dava una doppia dose di patatine fritte. Quello era il suo premio di consolazione. Tra le lacrime che gli velavano gli occhi e l’odio contro Piero che gli montava dentro senza ragione e proprio per questo senza alcuna possibilità di consolazione, il ragazzo diventava grande e la sua voglia di rivincita cresceva con lui, sempre più assurda, caparbia e incontrollabile come una malattia. Finché non cominciò ad ammalarsi sul serio.
Sua mamma aveva perso un fratellino di febbre tifoide e ogni volta che il ragazzo aveva l’influenza lei si disperava. A nulla servivano le parole del pediatra che frequentava assiduamente la casa e, dopo aver ficcato un cucchiaione in gola al figlio, tentava di tranquillizzarla che era solo una banale influenza. Lei si metteva le mani nei capelli e si tormentava senza sentire ragioni, finché una miriade di piccole efelidi rossicce le avvampavano il viso e il collo lungo alla Modigliani.
“Febbre ‘e crescenza” la liquidava la nonna con la saggezza dei suoi 80 anni passati tra guerre, carestie e morti premature e In effetti ogni volta che il ragazzino si alzava dal letto, era di qualche centimetro più alto. Ben presto superò il fratello e l’inesorabile ascesa delle sue tacche segnate col pennarello verde sul parato della cameretta lo consolò un pochino. Ogni mattina la mamma gli misurava la temperatura e se aveva la febbre lo metteva nel lettone, gli portava la spremuta, il caffellatte coi biscotti già spalmati di burro e marmellata, accendeva il mangiadischi arancione con le sue favole canore preferite, gli stampava un bacio sulla fronte bollente e se ne andava tutta preoccupata al suo lavoro di maestra elementare. Quando si fece più grande e imparò a leggere, intorno agli otto anni, gli comprò i Quindici. Così poteva leggersi le favole da solo oltre che guardare le figure. Il libro più consumato della serie era il numero 14: “Fare e Costruire”. Sulla copertina e sulla costa c’era un riquadro verde pisello con delle grosse forbici grigie in rilievo. Verso i dieci anni la mamma cominciò a passargli le sue riviste. Erano per lo più giornali di moda con grandi pagine piene di modelle altissime e magrissime ritratte a figura intera, in tacchi alti, minigonne mozzafiato e abiti eleganti, cappelli e borse di ogni foggia e dimensione. Fu allora che il ragazzo poté mettere in pratica quello che aveva imparato sul libro de I Quindici numero 14.
giovedì 18 marzo 2010
Sogno n° 2
Siamo in viaggio e facciamo visita a una moschea in Egitto o in Oriente. Siamo in pochi, due o tre persone al massimo. Di fronte a noi ci sono delle scritte in una lingua che non comprendiamo. In una parete c’è una fessura stretta in verticale che lascia intravedere appena quello che c’è dietro: un prato d’erba verde che risplende al sole, alberi maestosi e vegetazione lussureggiante. Sotto c’è una scritta minuscola come una didascalia o la targhetta di un museo. Riesco a leggere qualcosa. E’ scritta in inglese e dice qualcosa sulla via per il benessere. Torniamo dentro per cominciare la nostra visita all’interno della moschea e mi ritrovo davanti a un’altra parete di pietra nuda e massiccia: invalicabile. Iniziamo le prove di magia. Come riscaldamento dobbiamo trasformare la parete nei vari elementi delle Forze. Io dico “Oxossi” e la trasformo in una parete verde come un giardino verticale. Poi in un’altra cosa, ma quando mi concentro per trasformarla in fuoco non ci riesco. Arriva Marlene, la mia madre spirituale. Ora siamo tutti seduti in fila davanti a lei in attesa di prendere lezioni di volo. Comincia il viaggio astrale e io le chiedo di portarmi con lei in alto ma mi risponde che non sono ancora pronto e di restare a terra a osservare. Tre ragazze si librano in aria come fatine di Walt Disney, colorando la volta della moschea prima di giallo, poi di verde. Hanno una benda azzurra sugli occhi che serve loro per vedere con il terzo occhio, senza guardare con gli occhi fisici. A un certo punto la terza ragazza sta per cadere ma quella che la precede lo percepisce e con un delicato movimento della mano a mulinello verso l’alto la fa risollevare e la rimette in formazione di volo. Io trovo due bacchette magiche in terra come quelle di Harry Potter: una come nuova, l’altra un po’ bruciacchiata sulla punta. Resto un po’ a guardarle, indeciso su quale prendere.
Una dovrà pur essere per me, penso. O forse è proprio la mia, nel senso che l’ho usata per qualche magia e poi l’ho dimenticata? Certo quella nuova è più bella, ma se l’ho usata vuol dire che la mia è l’altra: quella bruciacchiata. E la tiro su. Adesso tutte le donne sfilano davanti a me come su un tapis roulant, lievitando più che camminando. La prima è in trance. Mi parla ma io non la capisco. Poi Marlene, capelli rossi accesi e vestito nero, mi dice qualcosa sulla guerra e passa avanti.
Finisce il viaggio astrale. Sento la musica della radiosveglia ma continuo a dormire. E faccio un altro sogno. Esco sul terrazzo di casa mia e chiedo al mio compagno perché ha chiuso la persiana. E’ una persiana verde e grande che nella realtà non esiste perché le nostre sono piccole e grigie. Quando le scosto, sempre nel sogno, vedo che c’è un nido d’uccelli tra i rami del gelsomino e che è nato un piccolo. Poi vedo che proprio in quello stesso istante sta uscendo il secondo uccellino con tutte le piume ancora bagnate. Ma non dal guscio dell’uovo: dalla vagina della madre. Sottile e verticale come una fessura. Mi sveglio. E’ caldo ed esco a fare colazione in terrazzo. La prima cosa che faccio è scostare la persiana e guardare il gelsomino.
Nascosto tra i rami più alti c’è un piccolo nido di merlo costruito con ramoscelli secchi, fili d’erba e qualche stella filante dello scorso Carnevale, intrecciati con cura a formare un’accogliente semisfera perfettamente mimetizzata tra la grondaia di rame e la tettoietta spiovente in vetro satinato del mio terrazzino. Incredibile ma al suo interno fanno capolino due uccellini appena nati che ripetono con i beccucci spalancati la loro insaziabile richiesta di cibo.
martedì 16 marzo 2010
Silvia (V parte)
“Silenzio per cortesia!”
Il professor Salvadori leggeva sempre la Gazzetta dello Sport prima di interrogare. Tutta la Gazzetta intendo. Aveva una testa piccola e rotonda con una chierica di capelli fini fini e due occhi aguzzi come spilli e vispi come quelli di un bambino furbetto e capriccioso. Le sue Clarcks sempre tenute slacciate ad arte sotto la cattedra erano un capriccio di gioventù; un souvenir del suo passato da intellettuale di sinistra che faceva a cazzotti con il grosso nodo alla cravatta incorniciato dalla V del maglioncino di lana, sotto il completo di flanella grigia. Le Clarks e le sue dita ingiallite dalla sigaretta perennemente accesa. Cento per cento esistenzialista. Tutto il resto rimaneva nascosto dietro alla Gazzetta che sfogliava tra un tiro e l’altro, con un unico ampio gesto della mano destra. Tra il prof e il ragazzo c’erano solo le pagine del giornale. Una cortina di pagine rosa come nubi al tramonto ma che al contrario delle nuvole, più si diradava più annunciava tempesta.
Un brivido freddo corse lungo la schiena del ragazzo quando si sentì chiamare per nome, o meglio per cognome.
“Coiro!”
Lui era sempre stato una negazione in matematica ma piuttosto che mettersi a studiare aveva preferito sedersi di fianco a qualcuno che se ne intendeva di quaderni a quadretti e così aveva conosciuto Silvia. Lei sì che ci sapeva fare con numeri e frazioni. Per non parlare delle interrogazioni programmate di fisica. Era un vero panzer. Si piazzava davanti alla lavagna col gessetto bianco in pugno e in men che non si dica liquidava qualunque problema. Manco a dirlo il ragazzo era impreparato e quel mercoledì Silvia era assente. Quello sì che era un problema. Lui non poteva saperlo ma la soluzione era scritta a lettere cubitali a pagina 21 della Gazzetta dello Sport: “Grande atletica ai campionati nazionali allievi. Coiro vola sui 110 ostacoli.”
“Parlano di lei?” chiese il professore inforcando meglio le lenti sul naso. Tutta la classe era immersa in un silenzio innaturale e mentre timidamente i più coraggiosi e i meno preparati cominciavano a tirare un sospiro di sollievo, il ragazzo rispose un timido sì. “Ebbravo Coiro. Io tengo in grande considerazione chi s’impegna nello sport e ottiene buoni risultati come lei” concluse.
Da quel giorno il ragazzo non fu mai più interrogato ma un bel 7 compariva magicamente sulla sua pagella ad ogni quadrimestre in matematica e fisica. Il figlio del prof Salvadori, come scoprì quel giorno, si allenava da anni sulla sua stessa pista di atletica senza essere mai riuscito a fare granché.
Ogni scarafone è bello a mamma sua, pensò il ragazzo. Forse con quel 7 dato a lui, il prof aveva sublimato gli sforzi del figlio –in un transfer degno di Freud e un po’ patetico per la verità- che aveva l’unico vantaggio di dare un po’ di umanità a quell’uomo altrimenti così impenetrabile agli occhi del ragazzo dietro le sue pagine rosa e le sue dita ingiallite. Valli a capire i genitori.
lunedì 15 marzo 2010
Silvia (IV parte)
“Ciao ragazzone,
 Il ragazzo si rigirò la lettera del vecchio allenatore tra le mani e con la matita per gli occhi di Silvia si mise a scrivere sul retro di quello stesso foglio. Con una foga irrefrenabile.
Il ragazzo si rigirò la lettera del vecchio allenatore tra le mani e con la matita per gli occhi di Silvia si mise a scrivere sul retro di quello stesso foglio. Con una foga irrefrenabile.
non sai quante volte avrei voluto farlo, ma solo oggi ho trovato la concentrazione giusta per scriverti, per parlarti…
Un paio di volte ho provato timidamente a cercarti, non ti ho trovato, non ho insistito.
Spero che finalmente abbia sistemato le tue cose, che i tuoi desideri si siano realizzati, e soprattutto mi auguro che non ti senti mai solo. Ma senz’altro la tua allegria, la tua capacità di stare insieme agli altri ti aiutano.
Parlare con te inevitabilmente mi porta a pensare all’atletica, alla nostra atletica che sono sicuro è ancora dentro di te così genuina e sincera come in me. Come quegli amori eterni, rari, ai quali ognuno di noi dedica un angolo del cuore e che ci fanno sentire un po’ diversi, speciali, orgogliosi e che ancora dopo dieci anni non riesco a riprovare.
A proposito, sono felice di dirti che ormai sono tecnico nazionale specialista del settore velocità e ostacoli, ma soprattutto mi piace raccontare appena posso le tue imprese, il tuo innato talento e la tua inimitabile eleganza nel superare le barriere. I tuoi record ancora imbattuti sono il mio maggior vanto e sono certo che se tu volessi potresti ancora oggi dire la tua.
Tu nel frattempo fatti vivo e se vieni al campo non fare il fesso che non ti fai vedere.
Io da un giorno all’altro spero di vederti arrivare con la tua andatura ciondolante, lo zainetto sulle spalle e il sacchetto con le scarpe chiodate in mano.
Luciano”
 Il ragazzo si rigirò la lettera del vecchio allenatore tra le mani e con la matita per gli occhi di Silvia si mise a scrivere sul retro di quello stesso foglio. Con una foga irrefrenabile.
Il ragazzo si rigirò la lettera del vecchio allenatore tra le mani e con la matita per gli occhi di Silvia si mise a scrivere sul retro di quello stesso foglio. Con una foga irrefrenabile.“Pronti… Via. Spingo i talloni sui blocchi di partenza e mi convinco: sono bassi, sono ancora come prima. Mentivo a me stesso come mi avevi detto di fare tu, sempre lì dietro di me a farmi coraggio, per cancellare la paura di quel metro e zero sette centimetri di altezza. E tante altre ancora. Come gli ostacoli anch’io sono diventavo grande. Lontano dalla rassicurante cerchia dei compagni di scuola, via dalla mamma chioccia in cerca di me stesso. Quanti ne ho cercati di uomini rassicuranti tra i volti dei mille ragazzi che ho incontrato. Sono rimasto me stesso: quel ragazzo avventuroso e misterioso che si incanta con la testa fra le nuvole e un papavero rosso in mano, appassito prima ancora di trovare risposta a una domanda così semplice. Eppure così difficile. Ma non mi fermo. C’è sempre un altro ostacolo da superare. Tra noi ce n’è uno bello alto. Ricordi quel giorno quando ci siamo salutati? Eri triste. Ero triste. Mi mancavano le nostre telefonate prima e dopo ogni allenamento, come se fossi tu il mio fidanzato. Ma tu eri e resti il mio allenatore. L’unico. Dopo di te l’atletica ha perso ogni valore. Lo ammetto, sono stato geloso degli altri ragazzi che allenavi, anche se so che neppure per te era più lo stesso. E poi, un giorno, la tua lettera. Una pagina d’inchiostro per riempire un anno di silenzi. Tu sposato, io gay. Entrambi, spero, felici nella nostra diversità di ritrovarci a parlare, un giorno. Senza più ostacoli.”
Silvia lo guardava fisso. Il ragazzo era tutto sudato, con il mozzicone della sua matita per gli occhi stretta in mano come un’arma. Avrebbe mai avuto il coraggio di spedire quella lettera al suo vecchio allenatore? Dopo tanto tempo? Forse lui già lo sapeva? Cominciò a montargli dentro un incontrollabile senso di nausea che ben presto si trasformò in un’orrenda sensazione di soffocamento. Gli mancava l’aria, gli ronzava la testa e stava per svenire quando, nel turbinio dei suoi pensieri e nell’addensarsi sempre più cupo delle sue più recondite paure sentì materializzarsi una voce interiore. Era un suono indistinto e monocorde, senz’alcuna inflessione dialettale, senza spessore, timbro o colore. Una voce senza volto e senza nome che proveniva da qualche profondità inesplorata del suo io, da un buco nero della sua coscienza.
“Morirai a 19 anni” gli disse quella voce e se ne andò lasciandolo lì da solo, all’improvviso, così com’era venuta.
“Un altro dei tuoi sogni a occhi aperti?” chiese Silvia. Poi aprì la borsa, tirò fuori il pacchetto di sigarette e l’accendino arancione e fece per accendersene una, ma poi stranamente la ripose. Fu allora che il ragazzo le chiese, anzi no, non le chiese ma con una certa sicurezza le disse: “Silvia… tu sei incinta.”
Silvia non sapeva cosa dire. Semplicemente esistono persone che non sono programmate per dire le bugie. E lei era una di quelle. Così, con la stessa semplicità con cui le aveva parlato il ragazzo, rispose sì. E si accese quella sigaretta.
“Danne una pure a me” fece il ragazzo avvicinandosi all’amica. Poi l’abbracciò con un tale slancio che si rotolarono tutti e due per terra, ridendo come disperati. Perché quando si è giovani si è disperatamente felici o disperatamente infelici, ma comunque disperati.
Si era fatto tardi. Cominciavano ad accendersi le luci dei lampioni del parco, violacee come la tinta fatta in casa di sua nonna che la faceva assomigliare alla fata turchina. Erano le cinque e dovevano ancora andare a casa a fare i compiti.
“E togliti di mezzo, coglione!” Il ragazzo non s’era accorto che era scattato il verde e un automobilista stressato gli stava smadonnando contro. Dopo avergli bestemmiato dietro mentalmente, il ragazzo saltò sul marciapiede opposto e si sedette a rifiatare sul cofano di un’auto parcheggiata, trovandolo piacevolmente caldo sotto il culo.
Ma dov’era finito quello svitato del suo amico? pensò Silvia e si mise una cicca in bocca cominciando a masticare furiosamente al ritmo dei suoi stessi passi. Odiava perdere tempo lei e soprattutto detestava perderlo per aspettare gli altri.
Il ragazzo la osservò allontanarsi senza trovare neppure la forza di urlare il suo nome mentre, rapida e sinuosa come una pantera, Silvia si faceva largo tra la folla che attraversava in direzione opposta le strisce pedonali della strada che divideva il parco delle Basiliche in due, sferzando con violente e involontarie cinghiate della sua giacca di pelle chiunque le si accostasse troppo.
venerdì 5 marzo 2010
silvia (III parte)
Rannicchiati sotto gli scatoloni alla stazione o nascosti agli angoli delle strade puzzolenti di urina. Quelli erano i veri uomini senz’ombra. Anzi gli uomini ombra. Potevano pure fare a meno di nascondersi, tanto nessuno si sarebbe mai accorto della loro presenza pensò il ragazzo e, quasi senza accorgersene, cominciò a tastarsi dappertutto. Portafogli, cellulare, chiavi. Era tutto al suo posto, eppure pareva che gli mancasse qualcosa: la sua ombra. Era l’una del pomeriggio ma il suo corpo non proiettava alcuna ombra. Fu assalito da un’assurda sensazione di assenza del corpo, di perdita d’identità che gli dette le vertigini. Se non c’era la sua ombra lui non esisteva, constatò, sorridendo al ricordo della favola di Peter Pan che in effetti non gli era mai piaciuta, neppure da bambino. Si voltò attorno per assicurarsi d’essere ancora lì nel mondo reale e non in uno dei suoi sogni. Ma il fatto che nessuno intorno a lui proiettasse l’ombra a terra non lo rassicurò di certo. Su una panchina al limitare del parco vide un uomo, gli occhi fissi nel vuoto, opachi e spenti, il corpo ridotto a un lumicino, la pelle sottile come carta velina che potevi vedergli l’anima in trasparenza. Chissà quante persone come quello lì c’erano in città. Uomini tutt’ossa, senza più l’ombra di un’emozione, senza più un briciolo di energia. Ossi di seppia alla deriva. D’improvviso l’uomo gli puntò gli occhi addosso.
“Cazzo guardi, stronzo?” abbaiò il ragazzo. Ma lo sguardo dell’uomo lo trapassò come se fosse un fantasma. “Stronzo di merda galleggiante pussa via in quest’istante” continuò a rimare mentalmente il ragazzo mentre si allontanava, calciando un sassolino di ghiaia che andò a finire al centro del laghetto con un plof e si allargò in cento cerchi concentrici.
Se la ricordava bene quella panchina. L’aveva vista tante volte in sogno. Ma invece che in un parco stava in mezzo a una strada lunga e dritta per poter prendere bene la rincorsa. Lui faceva una decina di passi e swoosh spiccava il volo, stando bene attento a non restare impigliato nei rami degli alberi più alti o nelle antenne della tv sui tetti dei palazzi. La città si spandeva subito sotto di lui, piatta e vischiosa come un barattolo di pece rovesciato in terra. Al centro si aggrumava il nero delle case che sbavava ai bordi in un grigio scuro, assecondando gli avvallamenti del terreno. Poi anche il grigio scompariva, avvolto nella nebbia o inghiottito da un enorme buco nero. E il sole se ne stava lì a guardare dietro una spessa lastra di nuvole all’orzata. Un cielo al neon proprio come quello lì.
“Viste ‘ste cazzo di nuvole?” disse il ragazzo all’amica che lo precedeva di qualche passo al ritmo della gomma masticante che le esplodeva in bocca in piccoli palloncini color fucsia. Silvia non rispose. Forse non aveva sentito, oppure aveva fatto finta di niente come al solito, abituata alle stranezze del suo amico.
Meglio così, pensò, contento che Silvia non l’avesse beccato un’altra volta con la bolla al naso, come diceva lei. Almeno non avrebbe dovuto affrontare il suo sguardo freddo e tagliente come un bicchiere di Brancamenta calato giù di botto, come in quel vecchio spot. Brrrrrr…. Un brivido freddo gli corse lungo la schiena come una scossa elettrica.
“C’è un unico lastrone di nuvole spesso come un iceberg su questa cazzo di città” continuò il ragazzo pensando a voce alta. Lui le amava le nuvole, quelle paffute e vaporose come panna montata, coi bordi bianchi e tondi che sembravano ritagliate nella carta con le forbicine e poi incollate con la coccoina sulla linea bombata dell’orizzonte. Ne aveva ritagliate una dozzina nel legno di balsa, colorate nei toni digradanti dal verde all’azzurro e le aveva appese al soffitto della sua cameretta con il filo trasparente della lenza. Così sembravano sospese in aria come quelle vere.
No che non era colpa della nebbia se a Milano non c’erano nuvole come quelle. Che poi l’aveva vista sì e no un paio di volte lui la nebbia in città, in tutta la sua vita. Piuttosto era l’impossibilità di spaziare con lo sguardo, la mancanza di un belvedere o di una collinetta per ammirare il panorama che gli mancava in quel mare di cemento, pensò il ragazzo guardando la Madunina in cima al Duomo, sempre con la testa tra le nuvole pure lei, proprio come lui. Palazzi su palazzi, addossati gli uni agli altri come muraglioni. Muraglioni di cemento armato, muraglioni di mattoni, muraglioni di vetro e acciaio tirati a lucido. A furia di vivere in mezzo a tutti ‘sti muri è naturale diventare cecati, pensò, osservando gli occhialoni verdi a mascherina inforcati sul naso dell’amica. Milano.
Palazzi su palazzi. Allineati e coperti come un esercito di soldatini di piombo chiusi in uno scatolone dei traslochi, con l’indirizzo scritto sopra a pennarello nero. Soldati che non ricordano più per cosa combattono ma sanno solo di aver perso l’unica cosa per cui vale la pena vivere: la voglia di giocare.
Silvia scelse un bello spiazzo d’erba sotto un tiglio, allargò la gonna a balze con una mezza ruota e si sedette. Poi, come se stesse leggendo nei pensieri del ragazzo fece: “Dicono che guardare il cielo rilassa il cristallino.”
“Peccato che in questa città è impossibile rilassarsi” rispose il ragazzo.
“Lo sguardo s’incurva sotto i tunnel della metropolitana, sotto le gallerie dello shopping, sotto i portici dei palazzi finché perdi anche il piacere di osservare, di cogliere le sfumature e i piccoli particolari che rendono ‘sta terra meno pallosa. Allora si cerca di ricreare all’interno dei palazzi la luce e il colore che manca fuori. Ecco perché a Milano ci si abbuffa di moda, design e pubblicità” concluse.
Poi alzò gli occhi e seguì una nuvoletta incrociare veloce nell’azzurro sopra la sua testa. La nuvola continuava a passeggiare in quel cielo a pecorelle e a lui sembrava di cadere all’indietro, nonostante fosse seduto a gambe incrociate e con le braccia ben piantate in terra. Indietro, indietro, sempre più veloce come in un film girato in rewind. Il ragazzo si sentiva risucchiato indietro nello spazio e nel tempo. Fu allora che si ricordò della lettera che aveva accartocciato distrattamente nella tasca posteriore dei blujeans il giorno prima e si decise ad aprirla.
giovedì 4 marzo 2010
Silvia (II parte)
“Uomini senz’ombra”. Li chiamava così i milanesi, il suo amico Levent nel suo mezzo-italiano-mezzo-turco. L’aveva conosciuto ad una festa anzi, pardon, a un party così esclusivo che non c’era praticamente nessuno a parte loro due, il padrone di casa e qualche sua amica. Ma fu comunque un incontro interessante, nato per un caso fortuito, o per meglio dire un incidente. Dopo aver fatto il suo ingresso nel lussuoso appartamento con terrazzo piantumato del padrone di casa -un tipo molto trendy che vendeva mazze da golf e collezionava boule-de-neige- il ragazzo si mise in un angolo in attesa che il party, come dire, decollasse. Fu dopo aver trascorso una buona mezz’ora lì da solo con le spalle contro il muro, come se dovesse reggerlo lui, che s’imbattè in Levent. Per la verità fu più per prendere una boccata d’aria che per un reale interesse che il ragazzo si decise ad avvicinarsi alla stravagante collezione di palle di neve in vetro provenienti da ogni parte del mondo che facevano bella mostra di sé sugli scaffali in mogano della libreria vicino alla porta finestra che dava sul terrazzo. E fu proprio lì che incrociò lo sguardo penetrante del turco che, manco a dirlo, non aveva mai smesso di fumare. Parlare con Levent era uno spasso. Nella variegata fauna di uomini-senz’ombra della sua personalissima Milano da bere avevano diritto di cittadinanza diversi gruppi di persone, ognuno col suo particolare modo di dire e di fare; ognuno col suo nespà immortalato in un’immagine e una didascalia: come una polaroid. I social-sucker erano quelli che arrivavano per primi alle feste e se ne andavano per ultimi ma rimanevano sempre un po’ in disparte, osservando tutto e tutti con aria indifferente senza mai fare un commento, dare un contributo o un tocco personale alla festa, ma succhiando letteralmente l’energia da tutti gli ospiti.
I pilow-kisser li riconoscevi subito da come ti salutavano mimando due bacetti delicati su ambo le guance, proprio come se stessero posando il viso sul cuscino, per poi passare a salutare qualcun altro, volando via di fiore in fiore, attratti dal profumo più intenso delle creme idratanti delle sciure: il profumo del lusso, come lo chiamava lui.
Le lady uffa-uffa -termine indistintamente usato per le donne vere e per le donne inside, cioè quelle imprigionate dentro il corpo di un uomo- si lamentavano sempre di tutto e di tutti, anche se in genere erano quelle che meno avevano da rimproverare alla vita o alla sorte. Erano le più ricche e immancabilmente anche le più stufe. “Just been there, just done that, spare me, spare me…” le imitava Levent intonando con vocina stridula il loro modo di parlare in perfetto queen english. D’altra parte le poverine avevano ben poco da divertirsi in quelle feste dove gli uomini erano al 90% gay. Levent non perdeva occasione per raccontare di quella sera in cui una di loro, mezza nuda e completamente ubriaca, si aggirava per le stanze semivuote di un appartamento a Mykonos urlando senza più neanche un briciolo di dignità “Any bisexual in the house?”
Le frociarole, come si può facilmente intuire, erano le amiche dei maschi gay. Quelle troppo brutte, troppo matte o troppo vecchie per avere un compagno vero, che preferivano la compagnia di amici gay, convinte in cuor loro di riuscire un giorno o l’altro a redimerne qualcuno. Povere illuse. E poi c’erano i barboni: i paria, gli invisibili della
mercoledì 3 marzo 2010
Silvia (I parte)
“Non riesco a respirare. Sento tutto lo smog che mi entra dentro il naso” disse il ragazzo all’amica bionda seduta a gambe incrociate di fronte a lui. Lei sollevò giusto un sopracciglio senza staccare gli occhi dal suo libro. Un sopracciglio solo. Faceva così quando c’era qualcosa che non capiva o non le andava a genio, o quando non aveva voglia di parlare e basta. Faceva quella faccia a punto interrogativo. Un panino al parco, aveva detto il ragazzo e lei aveva accettato, increspando un po’ le labbra in quel suo sorriso stretto. Nessuno ci faceva caso, ma a Silvia mancavano gli incisivi nell’arcata dentale superiore. Non le erano mai cresciuti e dopo anni di apparecchi fissi e mobili, anche adesso che ormai era tutto a posto, le era rimasto quel complesso. Neanche avesse un brutto sorriso, poi. Anzi quando rideva, e lo faceva spesso, le s’illuminava il viso di un bagliore verde-azzurro. Aveva due occhioni azzurri come laghi e nonostante li cerchiasse sempre con uno strato di matita nera troppo intenso e li nascondesse dietro un paio di occhialoni a mascherina verde scuro, le ridevano gli occhi a Silvia.
Era l’ultimo giorno di marzo e ti veniva voglia di abbinare il tuo umore al colore della primavera. Hai presente il verde speranza delle foglioline appena nate? il verde pisello dei teneri fili d’erba fresca? il verde oliva delle siepi di pitosforo? Ma poco più in là, oltre gli spartitraffico, il verde scuro delle parietarie e il verde marcio degli escrementi nei recinti di legno per i cani ti facevano parcheggiare subito quella voglia nelle strisce gialle riservate ai residenti.
La coppia di amici s’immerse in apnea tra le macchine che sbuffavano tra la scuola e il parco. Peccato sprecare una così bella giornata, pensò il ragazzo. Era l’una del mattino, c’era il sole o almeno doveva pur esserci il sole da qualche parte, oltre la lastra di nuvole di quel cielo al neon.
Strano, pensò, sentendo la ghiaietta del viale scricchiolare sotto la gomma delle sue scarpe da ginnastica con un suono ovattato. Quasi che i suoi occhi e le sue orecchie, di fronte all’orgia di stimoli visivi e olfattivi della natura al suo risveglio, ricercassero il letargo dell’inverno, anelassero al totale isolamento, si imponessero una deprivazione sensoriale volontaria. Come un pazzo masochista che dopo essere stato troppo a lungo rinchiuso in una stanza dalle pareti imbottite, di fronte al caos del mondo esterno preferisse tornare a rinchiudersi per sempre nella sua cella.
Perso nel loop di quei suoi pensieri il ragazzo continuava a camminare guardando le sue scarpe logore lievitare leggere sull’asfalto come il vampiro nel film del conte Dracula.
martedì 2 marzo 2010
Sogno n°1
Sono in India, in un luogo santo. Quattro donne italiane, anzi milanesi, mi si fanno attorno.
Loro sono alla fine della loro vacanza/ esperienza spirituale, io all’inizio. Una è vestita di verde chiaro, una di marrone scuro, una di celeste e l’ultima di rosa chiaro. Quella vestita di verde si siede a gambe incrociate a terra davanti a me e mi dice: “Ora ti diciamo qualcosa per te. Dopo la sua trentamillesima incarnazione, quando il Budda non era e non sarà più, tu sarai etero”.
Ora siamo seduti attorno a un tavolo di legno, pronti per il pranzo o alla fine del pranzo.
Un sant’uomo con le sembianze di Sai Baba, scuro di pelle e con un viso tondo incorniciato da riccioli folti e neri, gira alle nostre spalle incorporando uno spirito irascibile e violento e urla:
“Visto come sono tutto viola? Adesso ve lo faccio vedere io il viola come è violento se non fate quello che voglio io!” Io non oso alzare lo sguardo ma noto che lui non è vestito di viola ma di indaco e ha solo le pantofole del colore viola con due pompon attaccati sulla punta, come due asterischi pelosi che si rizzano a ogni passo.
Loro sono alla fine della loro vacanza/ esperienza spirituale, io all’inizio. Una è vestita di verde chiaro, una di marrone scuro, una di celeste e l’ultima di rosa chiaro. Quella vestita di verde si siede a gambe incrociate a terra davanti a me e mi dice: “Ora ti diciamo qualcosa per te. Dopo la sua trentamillesima incarnazione, quando il Budda non era e non sarà più, tu sarai etero”.
Ora siamo seduti attorno a un tavolo di legno, pronti per il pranzo o alla fine del pranzo.
Un sant’uomo con le sembianze di Sai Baba, scuro di pelle e con un viso tondo incorniciato da riccioli folti e neri, gira alle nostre spalle incorporando uno spirito irascibile e violento e urla:
“Visto come sono tutto viola? Adesso ve lo faccio vedere io il viola come è violento se non fate quello che voglio io!” Io non oso alzare lo sguardo ma noto che lui non è vestito di viola ma di indaco e ha solo le pantofole del colore viola con due pompon attaccati sulla punta, come due asterischi pelosi che si rizzano a ogni passo.
lunedì 1 marzo 2010
Prologo
I pesci del mare lo sapevano
che poteva volare.
Ma non lo andarono certo a raccontare.
Luca riuscì a stento a completare la frase che un doloroso crampo lo costrinse a mollare il pennello che stringeva nella mano sinistra. Era mancino. Il cotone della trapunta su cui stava dipingendo era così spesso da lasciare intravedere appena le parole della poesia che doveva ricalcare, e così assorbente che doveva tirare molto ogni pennellata per riuscire a tracciare con precisione il profilo di ogni lettera prima che l’inchiostro per tessuti asciugasse. Aveva stampato la poesia in un bel carattere corsivo su dei fogli A3, li aveva attaccati con lo scotch e stesi bene bene sul ripiano di vetro del tavolo della cucina, con l’abatjour accesa a terra. Per fortuna le setole erano quasi completamente asciutte quando il pennello gli volò via di mano. Ma una grossa goccia verde salvia cadde sulla trapunta, circondata da una corona di goccioline più piccole tutt’intorno, come un fuoco d’artificio. Luca scrollò la mano su e giù per sciogliere il crampo e le dita scrocchiarono come quando faceva la stecca al militare. Poi recuperò il pennello da terra e si mise a sedere ansimante per quel minimo sforzo, senza riuscire a farsene una ragione alla sua giovane età. Ma soprattutto pensando a come risolvere la faccenda.
Non voleva che la sua coperta fosse la più bella. Desiderava solo che fosse perfetta. Era il suo modo per farsi perdonare di tutti gli errori che aveva commesso nella sua vita. Ma la vita si sa è imprevedibile. Ti sfugge tra le dita quando meno te l’aspetti proprio come quel pennello e non puoi fare altro che cercare di riprendertela in mano e rimediare come puoi. Luca intinse la punta del pennello nella boccetta di acrilico verde e lasciò cadere qualche altra goccia qua e là sulla coperta, tra le parole “tatuaggio” e “ala” della poesia. Poi spense l’abatjour e la lasciò asciugare. Si guardò le mani. Erano livide e screpolate sul palmo e le vene sul dorso erano bitorzolute e viola a furia di siringhe. Aveva di nuovo la febbre. Si deterse la fronte imperlata di sudore con la mano del pennello e con l’altra si strappò via il cappellino di lana all’uncinetto che gli aveva regalato la madre a Natale e lo gettò a terra con un gesto d’insofferenza. Poi si trascinò stancamente sulle pantofole fino al mobiletto delle medicine in bagno. Nel riflesso dello specchio un vecchio con la barba incolta e capelli radi e sottili come la peluria di un neonato lo fissava con uno sguardo grigio e spento, pallido fantasma del bel ragazzo di un tempo. Prese il flacone di Atripla dalla mensola e lo vuotò nel cesso.
Iscriviti a:
Post (Atom)