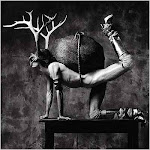In verità era abbastanza ricco da poter vivere di rendita anche prima di ricevere l’eredità –la sua era una delle più facoltose famiglie del New England-.
Oltre al delizioso appartamento coi mattoncini rossi e la vista sull’Hudson dove aveva portato il ragazzo la notte in cui si erano conosciuti, Andrew aveva anche una villa negli Hamptons dove non andava più tanto volentieri da quando aveva litigato col fratello e una piccola casa a metà strada tra New York e Boston. Era quella la prima tappa del loro viaggio. Solo Andrew con il suo understatement da perfetto WASP avrebbe potuto definire “piccola” una villa a due piani in stile coloniale con trecento ettari di parco e la vigilanza privata, immersa tra i boschi di querce secolari della splendida contea di Fairfield. Il ragazzo se ne innamorò all’istante. Della casa, ma soprattutto del parco col laghetto artificiale dove si abbeveravano i daini e i cigni nuotavano pigramente alla luce del sole che filtrava tra i rami delle querce.
Andrew trovava pretenziosa l’architettura della villa. L’ostentata opulenza degli arredi che al ragazzo piaceva tanto perché gli ricordavano i mobili della nonna, cozzava così tanto con la sbrietà del suo nuovo stile di vita che Andrew volle ripartire di buon ora il giorno dopo.
Quando arrivarono al Boatsleep Hotel non era neppure mezzogiorno e nella piscina dell’albergo –l’unica in tutta Provincetown- non c’era ancora nessuno. I primi ospiti si calarono nella hall ancora mezzi addormentati dopo la notte di baldoria in discoteca solo verso le due. In quel paio d’ore Andrew e il ragazzo poterono godersi la piscina e la vista dell’oceano in santa pace. Al ragazzo sembrò pure di scorgere in lontananza lo sbuffo di una balena che saliva in superficie a rifiatare e lanciò un urlo garrulo, ma Andrew
dovette prenderlo come uno dei suoi soliti sogni a occhi aperti – in pochi giorni aveva già potuto sperimentare le stranezze del giovane italiano e la sua folcloristica convinzione di essere una specie di medium- e non si alzò neppure dal lettino. Alle tre non ce n’era più uno libero. Uomini gay di tutte le età e di tutte le razze si spalmavano d’olio i corpi scolpiti dal work-out, il winstrol e il nandrolone sfilando nei loro speedo striminziti tra i lettini e il bar che già pompava musica dance a tutto volume. Alle quattro in punto il barman/dj urlò qualcosa nel microfono e simultaneamente tutti gli ospiti, come se fossero a una lezione di aerobica, presero i lettini e li ruotarono di 90 gradi per metterli in direzione del sole. L’operazione fu eseguita in così breve tempo e con una tale sincronia di movimenti che la folla esplose in un fragoroso applauso a cui aderirono eccitati sia Andrew che il ragazzo, gli unici lì in mezzo a non conoscere il famoso rito del Boatsleep.
La prima giornata in quell’oasi gay ai confini del mondo si concluse con uno strepitoso tramonto sull’oceano. Ma loro non lo videro. Erano troppo presi a fare l’amore tra le dune alle spalle della spiaggia. Nei giorni seguenti lasciarono la folla di “muscle mary” ai loro riti di adorazione del sole e si lanciarono alla scoperta della cittadina. Provincetown era sorta al posto di un antico villaggio di pescatori portoghesi arrivati in America sulla rotta delle balene che avevano deciso di stabilirsi in quella stretta lingua di terra sull’Atlantico, attratti dal suo clima mite e dal suo mare ricco di pesce.
Con la messa al bando della caccia alle balene da parte del governo degli Stati Uniti le povere case dei pescatori erano state prima affittate agli hippie, poi acquistate da una esigua cerchia di intellettuali e artisti in cerca di tranquillità e d’ispirazione. Alla fine erano state trasformate in ristoranti e gallerie d’arte che avevano mantenuto intatto il loro fascino naif, attraendo la ricca ed esigente comunità gay del New England, in fuga dal bigottismo dell’alta borghesia americana in vacanza agli Hamptons. Come New York aveva la sua Fire Island, così ora Boston aveva la sua Provincetown.
sabato 12 febbraio 2011
lunedì 7 febbraio 2011
Andrew (VII parte)
“Nice to meet you!” fece con enorme piacere dando la mano ad Andrew, dopo averla estratta ancora calda dall’incavo in mezzo alle sue cosce.
Andrew gli strinse la mano, lo trasse a sé e gli infilò la sinistra tra le chiappe, facendosi largo con grande abilità nei jeans attillati del ragazzo. L’effetto sul ragazzo fu immediato e inequivocabile. Andrew capì in un solo gesto le dimensioni e le sue preferenze sessuali, e fu sicuro che gli sarebbe piaciuto.
Si chiamava Andrew Lush. Lush come lussuria, pensò il ragazzo mentre si addormentava con la testa sul suo petto, dopo una notte di sesso travolgente. Furono svegliati dal suono incalzante delle sveglie dei rispettivi cellulari, sincronizzate entrambe sulle 8. Fu così che scoprirono -con un certo sollievo, come si sarebbero confessati in seguito- di essere entrambi sieropositivi. Forse fu quel piccolo incidente, forse fu il fascino fatale della grande mela che gli aveva finalmente offerto un incontro interessante: la verità è che il biglietto di ritorno per l’Italia non fu mai usato. Il ragazzo continuò il tour dell’America con il suo nuovo lussurioso amore. Nel viaggio in auto verso Boston scoprì che Andrew era un giovane avvocato ebreo di una decina d’anni più grande di lui che “aveva fatto il giro completo della giostra” come diceva lui, ma che ormai non usciva quasi più. Era stato solo un caso se quella sera l’aveva incontrato al Palladium. Era il compleanno di Ted, il suo migliore amico –gliel’aveva presentato in discoteca ma il ragazzo non se lo ricordava proprio- e dopo la cena a sorpresa che Andrew aveva organizzato con amici comuni a casa sua, tutto il gruppo l’aveva convinto a mettersi su qualcosa per andare a ballare. “Qualcosa che non comprendeva le mutande, eh?” commentò il ragazzo ingranando la quinta.
“Probablymente ero fuori, baby” continuò con un sorriso sornione “You know, my K is the best in town!”
Andrew aveva mantenuto solo quella cattiva abitudine della sua vita precedente. Lui lo chiamava “the circuit”: un vero e proprio circuito fatto di party esclusivi e locali di tendenza dove si davano appuntamento tutti i “muscle mary” come lui: giovani gay palestrati, sballati e spensierati. “Niente più christal, exstacy o speed” si difendeva lui, snocciolando i nomi delle più letali sostanze stupefacenti in circolazione con voce da santarellino. “Solo un po’ di K una volta ogni tanto. Solo nelle occasioni speciali. Per questo si chiama special, no?” sorrideva agitando la fiala di ketamina sotto il naso del ragazzo in attesa della sua approvazione. La sua K era davvero speciale. Mica la cuoceva nel microonde, lui. Troppo chip! La lasciava essiccare lentamente sul davanzale del balcone al sole di Manhattan. Il risultato era una droga più “naturale” –da buon americano mimava le virgolette con un rapido movimento dell’indice e del medio- ma dall’effetto davvero straordinario. Il ragazzo poteva confermarlo. A parte quello, da quando si era scoperto sieropositivo Andrew aveva completamente cambiato vita. S’era messo in pensione dopo quarant’anni di “I and law” come amava dire lui, giocando sull’ambiguità della pronuncia inglese che poteva riferirsi tanto alla sua carriera di avvocato, quanto agli “high and low” delle droghe.
Iscriviti a:
Post (Atom)