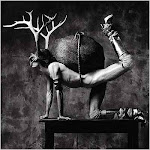Per non parlare di quel ragazzo coi capelli rasati, il nasone, gli occhialoni a mascherina, gli auricolari dell’i-phone –bianchi pure quelli- ficcati nelle orecchie e il tatuaggio tribale –Maori, si dice così?- che gli tagliava a metà il polpaccio per il lungo e gli si avvolgeva a cerchio sul mallelolo –gli avrà fatto male?- pure quello gli piaceva un sacco. Ma era meglio non pensarci sennò gli veniva duro e doveva andare a farsi una pippa in bagno. E il bagno dell’aereo si sa non è poi così comodo. Eppoi faceva un freddo cane…
Si voltò in cerca di una hostess e vide quel businessman segaligno seduto dall’altra parte del corridoio col suo completo verde cacca, i lacci sporchi di cromatina mal tirata e quegli imperdibili, imperdonabili calzini azzurrini! Che orrore, pensò il ragazzo. Meglio concentrarsi sulla battuta da fare alla hostess sull’aria condizionata, l’era glaciale e via discorrendo. Chissà che effetto farà a quella bionda dai begli occhioni blu che continua a sculettare avanti e indietro per tutto il corridoio con quella sua aria da teutone sfigata che gli sta così sul cazzo. Lei come da copione sgambetta fino alla sua poltrona, spegne la lucetta intermittente di chiamata con un gesto rapido e meccanico che non riesce tuttavia a nascondere una certa dose di fastidio e si sforza di sorridergli. Ma ci riesce solo a metà: con la bocca. Gli occhi li tiene fissi sulla tua polo con la coroncina bianca, i tuoi bermuda bianchi, i tuoi denti bianchi e il tuo pizzetto bianco. Ma poi ti manda quel frocetto del capocabina, pensando che con i suoi modi da frocio consumato e la sua parlata affettata ti capisca meglio e tu la finisca di rompere i coglioni. Invece la cosa ti fa solo incazzare di più. Ma a te piace troppo mostrarsi educato ed elegante per fare una scenata. E poi guardalo come ti osserva. Ti si farebbe così su due piedi, anche nel bagno dell’aereo. Anzi forse lì si eccita di più e chissenefrega se si sta stretti, tanto in ginocchio ci finirebbe lui e alla fine non dovresti neppure tirare lo sciacquone. Che con quelle mani sottili e ben curate, seghe e pompini devono essere la sua specialità -altro che Irina Palm-. E il cazzo che ti stava già venendo duro, facendo capolino da sotto la tela bianca dei bermuda se ne va giù e scompare nelle mutande. Così finisce che gli dici che non fa niente, che adesso va meglio e ti riaccoccoli nella tua poltrona. Lui ti sorride coi suoi denti bianchi e dal taschino della camicia bianca tira fuori il suo biglietto da visita col suo cellulare scritto sul retro, “per qualsiasi cosa ti possa servire nella Grande Mela… Daniel Sanchez, ma tu chiamami Dan.”
Lo lasci andare, poi chiedi permesso alla cicciona, ti alzi e vai a chiuderti in bagno.
Tiri fuori la pallina di coca dalla tasca dei bermuda e col biglietto da visita di Dan ti stendi due righe bianche sull’asse del cesso e tiri, coperto dal rumore dello sciacquone, mentre il tuo aereo infila un banco di nembi nel cielo sopra New York.
“Grazie Dan, ma ho tutto quello che mi serve”.