Era un uomo duro suo padre. Autorevole e determinato come il suo nome da centurione romano lasciava immaginare: Tullio. Il ragazzo l’aveva visto piangere solo quella volta, ascoltando la cassetta registrata da Alex. Poi suo padre gli aveva chiesto di lasciarlo perché Alex era troppo grande per lui e poteva “plagiarlo”. Di farlo per lui. Poi d’accordo con l’allenatore l’aveva mandato in ritiro a Formia, nella stessa fottuta scuola di atletica leggera dove il ragazzo giocava a fotocopiarsi il cazzo con gli amici. Solo che stavolta era lì da solo. E con doppia razione di bromuro a colazione. Ogni sera, quando lo chiudevano a chiave nella camerata deserta, il ragazzo guardava fuori alla finestra e vedeva i due grandi fanali della squalo che lampeggiavano tristemente, prima di accendersi per l’ultima volta e riportare Alex ad Anguillara.
Era un uomo tenero suo padre. Solo che non sapeva come esprimerlo. Mai un abbraccio, mai un bacio. Solo qualche carezza. Delicata e lieve come un fiocco di neve. Ricordava quando suo padre usciva dallo studio e si avvicinava alle sue spalle in punta di piedi, per non distrarlo mentre studiava. Dava uno sguardo ai compiti e poi, furtivamente, gli passava la mano tra i capelli. Un paio di volte e basta. In silenzio. Poi tornava alle sue visite. Ora che il ragazzo viveva a Roma ogni tanto gli telefonava. Gli aveva scritto una volta soltanto.
“Caro figliolo,
che consolazione lo scrivere quando non si riesce a esprimere come si vorrebbe i propri sentimenti. Tu e tuo fratello, insieme alla mamma, siete tutta la mia vita e i miei affetti poiché tanti –forse perché fasulli- ne ho persi per strada. Oggi recrimino di aver troppo badato alla sostanza e troppo poco alla forma, forse a causa dell’educazione forzatamente spartana ricevuta dalla mia famiglia. Ti voglio bene figliolo e -proprio per non farti soffrire delle mie ristrettezze- preferisco darti qualche soldo per le tue esigenze oggi che ne hai bisogno e non domani, quando certamente te lo sarai procurato perché vali. Il successo verrà, ne sono sicurissimo. Invece ti prego di essere per tuo fratello quello che Olga –dolcemente ma sempre tenacemente- è stata per me. Un abbraccio. Papà.”
Il ragazzo non trovò mai il tempo di rispondere a quella lettera o forse non trovò le parole. Oppure, come avrebbe capito una domenica qualche anno più tardi, doveva solo leggerla quella lettera. Come si fa coi testamenti. Quella domenica era tornato in anticipo dalla sua gita fuori-porta. Il magnifico giardino della villa del suo amico si affacciava sui colli verdeggianti dei castelli romani. Splendeva il sole e subito dopo pranzo il ragazzo s’era andato a sdraiare sull’erba perfettamente rasata del prato all’inglese, fregandosene di macchiarsi i jeans nuovi e il maglioncino di cachemire color crema. Era così bello lì e per la prima volta dopo tanto tempo si sentiva finalmente libero e sereno. Soddisfatto del suo nuovo gruppo di amici e segretamente lusingato di essere entrato nelle grazie del più ricco fra loro. Ci sarebbe rimasto tutto il giorno steso sull’erba, nonostante fosse un po’ umidiccia, ma aveva un freelance da fare e costrinse un amico a riaccompagnarlo a casa, lasciando gli altri a raccontarsi le loro vacanze alla luce di quel pigro tramonto di fine settembre. L’amico lo scaricò davanti al teatro sexy Volturno e ingranò la prima, salutandolo con un breve colpo di clacson. Fu proprio allora, mentre passava davanti all’Ibiza in panne parcheggiata nello stretto budello di Via Calatafimi, che il ragazzo sentì la voce che diceva: “Papà è morto”.
Non le diede retta, ma il brusco rallentamento del meccanismo idraulico dell’ascensore all’arrivo al quarto piano lo fece sobbalzare. Appena entrato in casa come d’abitudine controllò la segreteria telefonica hi-tech che si era fatto mandare dall’America. L’aveva vista in casa di uno dei suoi one-night-stand dove aveva passato la notte un altro paio di volte, giusto per scoprire dove l’avesse presa quella meraviglia. Sulla spia dei messaggi lampeggiava incessantemente un 1 rosso e il ragazzo premette il pulsante di lettura. Una scarica d’adrenalina gli saettò lungo le gambe quando sentì la voce tremante di sua madre che cercava di trovare le parole giuste per avvertirlo senza allarmarlo troppo sulle condizioni di salute di suo papà. Tullio era in ospedale. Il cuore. Il ragazzo si precipitò in stazione così com’era e prese il primo treno per Milano. Trovò la mamma e il fratello inginocchiati davanti alla statua di gesso della Madonna nella sala d’attesa del reparto rianimazione. Poveri illusi. Lui lo sapeva che il padre non ce l’avrebbe fatta. Si era addormentato in treno, con il testo della brochure per la forza vendita Renault che avrebbe dovuto consegnare l’indomani mattina in agenzia ancora stretto tra le mani, quando si era sentito avvolto da un forte abbraccio. Aveva aperto gli occhi ma non c’era in giro nessuno. Era stato suo padre. L’aveva voluto salutare così, ne era sicuro, con quel calore che non era mai riuscito a dargli in tutta la sua vita. I dottori dissero che non c’era stato nulla da fare, che il suo cuore era stato squassato in due dall’infarto.
Aveva il cuore tenero suo padre. Lo consolarono dicendo che praticamente non aveva avuto neanche il tempo di soffrire. Ma dai pianti inconsolabili di sua madre che se l’era visto morire tra le braccia -e che per il resto della sua vita da vedova non si sarebbe mai perdonata il fatto di non essere riuscita neppure ad asciugare il sudore freddo dalla fronte del marito- il ragazzo capì che era una pietosa bugia. Strano come i cadaveri sembrano ancora muoversi se li osservi abbastanza a lungo. In quella umida sala mortuaria affacciata sul parcheggio dell’ospedale il ragazzo aveva avuto tutto il tempo che voleva per stare solo con lui. A osservarlo così, in silenzio, senza che fosse lui a cercare il tuo sguardo per vedere se stavi attento mentre ti leggeva i suoi articoli di giornale, sembrava che dormisse. Ma era troppo smagrito e pallido in quel pigiama azzurro. E poi suo padre non portava mai i pantaloni del pigiama. Lo aveva scoperto con una certa sorpresa una domenica mattina della sua infanzia e da quel giorno non aveva più smesso di fantasticarci sopra. Lo abbracciò forte per sentire il calore del suo corpo e gli strinse forte la mano. Era fredda come la lastra di marmo grigia su cui era disteso. Poi qualcuno aprì a forza la bocca di Tullio, gli tolse la dentiera e la ripiegò in un fazzoletto. In quel momento il ragazzo risentì quella voce e capì che suo padre era morto davvero. Maledetta voce interiore. Gli aveva ripetuto tante di quelle volte che sarebbe morto a 19 anni, che il ragazzo se n’era fatto una ragione. Anzi ci scherzava su. Immaginava di starsene con la sua anima appesa al soffitto della chiesa per vedere chi avrebbe pianto di più al suo funerale. E vuoi per distrarsi, vuoi perché mal comune è mezzo gaudio, si era sorpreso a fare lo stesso macabro calcolo mentale al funerale del fratello, della mamma e del papà e a domandarsi per chi di loro avrebbe pianto di più. Che nella testa del ragazzo equivaleva a dire: a chi vuoi più bene? Quel giorno in chiesa il ragazzo non avrebbe più smesso di frignare se dallo scanno di fianco sua madre non gli avesse intimato -lei sì piangendo-: “Non piangere. Non ti permettere di piangere!”
Il ragazzo obbedì, ma fu uno sbaglio. Se ogni lacrima avesse un colore diverso, se si potessero riconoscere le lacrime versate per uno o per l’altro, si sarebbe accorto che anche quando si commuoveva per un film al cinema o in tv, dava ancora sfogo al pianto interrotto per suo padre.
Era uno con la lacrima in tasca, diceva Silvia, mimando con le mani arricciate a mo’ di artiglio le lacrime aggrappate al bordo delle ciglia, sempre sul punto di cadere. Il ragazzo non se ne fece mai un problema, ma provò un certo imbarazzo quando il suo boyfriend olandese gli confessò che “doppie” -il soprannome che gli aveva appioppato- significava letteralmente “lacrimuccia”.







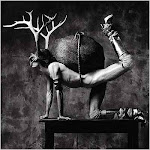



Nessun commento:
Posta un commento